Ipnocrazia: quando l’intelligenza artificiale diventa filosofo e il giornalismo inciampa
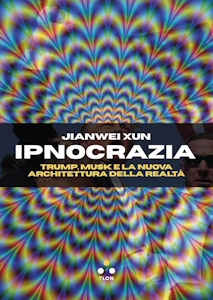 Nel gennaio 2025, un libro intitolato Ipnocrazia – Trump, Musk e la nuova architettura della realtà ha fatto il suo ingresso nel panorama editoriale italiano, pubblicato da Edizioni Tlon. Firmato da un misterioso filosofo di Hong Kong, Jianwei Xun, il saggio prometteva di analizzare i meccanismi del potere nell’era digitale, con particolare attenzione a figure come Donald Trump ed Elon Musk, descritti come “sacerdoti” di un nuovo regime che manipola la percezione collettiva. Il libro ha rapidamente attirato l’attenzione di testate prestigiose come Il Foglio, Le Figaro e Le Grand Continent, e persino il presidente francese Emmanuel Macron ne avrebbe lodato le intuizioni. Ma c’era un problema: Jianwei Xun non esiste. Dietro il nome si cela un esperimento culturale orchestrato da Andrea Colamedici, fondatore di Tlon, che ha utilizzato l’intelligenza artificiale per creare non solo il testo, ma anche l’autore stesso, complete di biografia e foto generate digitalmente.
Nel gennaio 2025, un libro intitolato Ipnocrazia – Trump, Musk e la nuova architettura della realtà ha fatto il suo ingresso nel panorama editoriale italiano, pubblicato da Edizioni Tlon. Firmato da un misterioso filosofo di Hong Kong, Jianwei Xun, il saggio prometteva di analizzare i meccanismi del potere nell’era digitale, con particolare attenzione a figure come Donald Trump ed Elon Musk, descritti come “sacerdoti” di un nuovo regime che manipola la percezione collettiva. Il libro ha rapidamente attirato l’attenzione di testate prestigiose come Il Foglio, Le Figaro e Le Grand Continent, e persino il presidente francese Emmanuel Macron ne avrebbe lodato le intuizioni. Ma c’era un problema: Jianwei Xun non esiste. Dietro il nome si cela un esperimento culturale orchestrato da Andrea Colamedici, fondatore di Tlon, che ha utilizzato l’intelligenza artificiale per creare non solo il testo, ma anche l’autore stesso, complete di biografia e foto generate digitalmente.La genesi di un esperimento culturale
L’idea di Ipnocrazia nasce da una riflessione di Colamedici, filosofo e docente di Prompt Thinking allo IED di Roma, sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella costruzione della realtà contemporanea. In un’intervista a L’Espresso del 4 aprile 2025, Colamedici ha rivelato di aver collaborato con strumenti come ChatGPT e Claude per generare il contenuto del libro, creando un finto filosofo per incarnare le tesi del saggio: il potere oggi non opprime, ma seduce attraverso “narrazioni ipnotiche” che consumiamo e condividiamo. L’esperimento non si limita alla teoria: il libro stesso diventa una dimostrazione pratica di come la realtà possa essere manipolata. La biografia di Xun, le sue presunte pubblicazioni e persino le recensioni entusiastiche di testate internazionali sono parte di un’operazione meta-narrativa che ha “ipnotizzato” giornalisti, editori e lettori.
Il caso è esploso quando Sabina Minardi, caporedattrice de L’Espresso, ha cercato di contattare Xun per un’intervista, scoprendo che non esisteva traccia reale della sua esistenza. Le sue indagini hanno rivelato un’operazione sofisticata: il volto di Xun era stato generato dall’IA, la sua biografia era stata inserita su Wikipedia, e persino le citazioni di studi accademici erano fittizie. Eppure, il libro aveva venduto migliaia di copie – circa 4.000 nei primi tre mesi – ed era stato celebrato come un’opera rivoluzionaria. In Francia, Le Figaro aveva pubblicato un’intervista con il filosofo inesistente, e Gallimard aveva cercato di acquisirne i diritti. La rivelazione ha scatenato un dibattito globale, non solo sull’uso dell’intelligenza artificiale, ma anche sulla credulità del giornalismo contemporaneo.
Un’analisi del fenomeno: tra filosofia e provocazione
Ipnocrazia introduce concetti come “economia della trance” e “ipnosi probabilistica” per descrivere un mondo in cui la realtà è “gassosa”, come la definisce Colamedici, ossia priva di un confine netto tra vero e falso. Secondo il libro, figure come Trump svuotano il linguaggio di significato, mentre Musk ci intrappola in promesse utopiche mai realizzate, creando uno stato di ipnosi collettiva. Ma l’aspetto più interessante dell’esperimento è la sua natura performativa: il libro non si limita a descrivere il fenomeno, lo incarna. La creazione di Jianwei Xun dimostra quanto sia facile costruire una narrazione credibile nell’era digitale, sfruttando la nostra predisposizione a fidarci di ciò che appare autorevole.
Il caso solleva questioni profonde sull’autorialità e sul ruolo dell’IA nella cultura. Se un libro scritto da un’intelligenza artificiale può essere celebrato come un’opera filosofica, cosa significa essere un autore oggi? Colamedici, nell’intervista a L’Espresso, sottolinea che l’IA non deve essere usata per delegare il pensiero, ma per imparare a pensare meglio. Ipnocrazia diventa così un invito a riflettere sui rischi e le opportunità dell’intelligenza artificiale: da un lato, la possibilità di creare nuove forme di sapere; dall’altro, il pericolo di una manipolazione sempre più sofisticata della realtà.
Critica: il giornalismo sotto accusa
Il caso Ipnocrazia mette in luce una crisi profonda nel giornalismo contemporaneo. Come è possibile che testate autorevoli abbiano recensito un libro senza verificare l’esistenza del suo autore? La risposta sta nella velocità e nella superficialità che spesso caratterizzano l’informazione digitale. Giornali come Le Figaro e Il Manifesto hanno dato per scontata l’autenticità di Xun, attratti dall’aura esotica di un filosofo di Hong Kong e dalla pertinenza delle sue tesi. Questo episodio richiama alla mente un’osservazione di Umberto Eco: in un mondo di informazioni infinite, la capacità di distinguere il vero dal falso diventa una competenza cruciale, ma sempre più rara.
La reazione isterica sui social, come riportato da Linkiesta, evidenzia un altro problema: le relazioni parasociali che ci legano a figure pubbliche. Molti lettori si sono sentiti “traditi” dalla rivelazione, non tanto per il contenuto del libro, quanto per il legame emotivo che avevano instaurato con l’idea di Xun. Questo fenomeno, secondo Linkiesta, è la vera cifra del XXI secolo: non ci importa tanto della verità, quanto della narrazione che ci fa sentire parte di qualcosa. Il caso Ipnocrazia dimostra che il giornalismo non può più limitarsi a riportare notizie, ma deve tornare a essere un baluardo di verifica e approfondimento, soprattutto in un’epoca in cui l’IA può creare finzioni così convincenti.
Un esperimento che lascia il segno
Ipnocrazia non è solo un libro, ma un evento culturale che ci costringe a interrogarci sul nostro rapporto con la realtà. Andrea Colamedici, con il suo esperimento, ha messo in scena una provocazione filosofica che va oltre il testo: ci ha mostrato quanto siamo vulnerabili alla manipolazione, ma anche quanto possiamo essere creativi nel navigare un mondo di narrazioni multiple. Per il giornalismo, è un campanello d’allarme: in un’era in cui l’IA può generare autori, libri e persino dibattiti, la verifica delle fonti non è più un optional, ma una necessità.
Il caso di Jianwei Xun ci lascia con una domanda: siamo pronti a vivere in un mondo in cui la verità è solo una delle tante storie possibili? Forse, come suggerisce Colamedici, la risposta non sta nel cercare una verità assoluta, ma nel sviluppare una “literacy della realtà” che ci permetta di abitare consapevolmente il caos. Una sfida che, in questo 2025, non possiamo più ignorare.
