Transfer pricing “fuori legge” anche senza risparmio di imposta
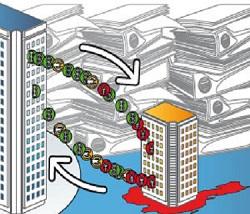 Il transfer pricing è illegittimo anche nel caso in cui non venga provato l’effettivo risparmio di imposta, perché è sempre comunque distorsivo della concorrenza. Questo, in sintesi, è il principio affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 20805 del 6 settembre 2017.
Il transfer pricing è illegittimo anche nel caso in cui non venga provato l’effettivo risparmio di imposta, perché è sempre comunque distorsivo della concorrenza. Questo, in sintesi, è il principio affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 20805 del 6 settembre 2017.
Una multinazionale ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano un avviso di accertamento recante una pluralità di rilievi ai fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno 2003, riprendendo a tassazione sulla vendita di prodotti finiti e principi attivi per la commercializzazione fuori dall’Italia nei confronti di una controllata.
In particolare, in base al contratto di licenza tra le società del gruppo, il prezzo non poteva essere inferiore al 150% del costo pieno di produzione (prodotti confezionati) e in certi casi al 200% (prodotti finiti e principi attivi).
L’ufficio, dunque, rilevando che per un unico prodotto vi era stato un ricarico inferiore, aveva recuperato a tassazione la differenza, ritenendo che il prezzo contrattualmente stabilito poteva commisurare il valore normale dei beni compravenduti.
La Ctp di Milano annullava parzialmente l’accertamento, con sentenza poi impugnata sia dall’Agenzia delle entrate sia, con appello incidentale, dalla contribuente.
Ambedue gli appelli sono stati poi accolti in parte dalla Ctr Lombardia, contro la cui sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, sulla base di svariati motivi, tutti ritenuti inammissibili o infondati dai giudici di legittimità.
La decisione della Corte
Con la pronuncia in comento, la suprema Corte ha ritenuto infondate le difese della contribuente, volte a giustificare il proprio operato, sostenendo che lo sconto praticato alla controllata doveva ritenersi giustificato nell’ambito del rapporto, in considerazione degli obiettivi commerciali perseguiti.
Tale linea difensiva, infatti, ad avviso della Cassazione, trascura che l’aspetto essenziale del transfer pricing non riguarda la giustificazione del minor prezzo dal punto di vista economico, ma se gli sconti possono ritenersi giustificati dal punto di vista fiscale, se rispondono cioè al principio di libera concorrenza, in conformità agli insegnamenti della suprema Corte.
In particolare, il fenomeno del transfer pricing è stato ritenuto sussistente nel caso in esame, in cui erano state effettuate transazioni tra società appartenenti a uno stesso gruppo, ma con sede in Paesi diversi, per prezzi che non hanno corrispondenza con quelli praticati in regime di libero mercato, poiché, dal lato economico, ciò aveva comportato un’alterazione delle condizioni della libera concorrenza.
Il transfer pricing, infatti, ad avviso della Corte, dà luogo a uno spostamento di imponibile fiscale, cosicché, proprio allo scopo di preservare l’esatta pretesa impositiva di ciascuno Stato, sono state adottate normative nazionali predisposte a eliminare il fenomeno stesso: normative che recepiscono il principio del prezzo normale delle transazioni commerciali, contenuto nel modello Ocse articolo 9, comma 1, convenzione del 1995.
Tale principio, del resto è stato recepito anche in Italia, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Corte, dal Dpr 917/1986, articolo 76, comma 5 (Cassazione n. 10742/2013).
La sentenza, dunque, conferma la più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la normativa in materia di transfer pricing non integra una disciplina antielusiva, in senso proprio, perché (a differenza di altre norme specificamente antielusive) non prevede che l’amministrazione finanziaria debba provare la maggiore fiscalità nazionale – ed è perciò applicabile anche in difetto di prova da parte dell’amministrazione – del conseguimento di un concreto vantaggio fiscale da parte del contribuente.
Detta disciplina, in altri termini, rappresenta una difesa più avanzata di quella direttamente repressiva della elusione, in quanto è rivolta a reprimere il fenomeno economico in sé. Viene perciò ribadito l’orientamento dei Giudici supremi secondo cui, in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’articolo 76, quinto comma, del Tuir, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell’amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l’esistenza di “transazioni” tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale.
Grava invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova (articolo 2697 cc) e in tema di deduzioni fiscali (cfr Cassazione nn. 9917/2008 e 19489/2010), l’onere di dimostrare che tali “transazioni” sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua dell’articolo 9, terzo comma, del menzionato decreto, secondo cui sono da intendersi normali i prezzi di beni e servizi praticati “in condizioni di libera concorrenza”, allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi e con riferimento “in quanto possibile” a listini e tariffe di uso, non escludendosi pertanto l’utilizzabilità, al descritto fine, di altri mezzi di prova (cfr Cassazione nn. 11949/2012, 10739 e 10742 del 2013 e 8849/2014).
Peraltro, viene ribadito che, se in linea generale, non si può escludere che considerazioni di strategia complessiva inducano le imprese a compiere operazioni di per se stesse antieconomiche in vista e in funzione di altri benefici, tuttavia è necessario che le varie operazioni rispondano a criteri di logica economica, i quali, a loro volta, devono essere funzionali a meccanismi di mercato in regime di libera concorrenza, non distorsivi di tale regime (Cassazione n. 17955/2013).
